Narrativa / Nell’esordio di Flora Fusarelli (4 Punte Edizioni) la storia di un dramma e della forza femminile. Tre generazioni, dalle nonne alle nipoti, affrontano la guerra e la violenza maschile

Decidere di avere ugualmente un figlio dopo uno stupro, forse soltanto una donna può pensarlo. E forse nemmeno una donna in quanto tale, ma unicamente la donna stuprata. Dev’essere un atto d’amore immenso, insondabile,
inconcepibile per pura razionalità o per una impennata di orgoglio titanico. Ne ha parlato una decina di anni fa Margaret Mazzantini nel suo bel libro Venuto al mondo (Mondadori) — dal quale il marito Sergio Castellitto ha poi tratto l’omonimo film — nel quale l’autrice racconta di uno stupro di guerra, gli infami «stupri etnici» della guerra dei Balcani negli anni Novanta. Ma quella era la guerra, che abitua il cervello umano, i lettori, gli spettatori, ad aspettarsi qualsiasi turpitudine, salvo poi inorridire e denunciarla a cose fatte, e magari a urlarla in un libro o in un film.
Uno stupro consumato nel silenzio, invece, in un borgo minuscolo, sbrigato come una pratica burocratica, premeditato dal giovane e rampante notabile del luogo per punire la ragazza — la più bella del paese, povera, onesta — che non lo vuole e ama un altro, è, se possibile, uno stupro ancora peggiore di quelli «di guerra». Ma rivela ancora meglio, come racconta Flora Fusarelli nel suo romanzo d’esordio, Le deboli (4 Punte), tutta la forza delle donne, specialmente quando vivono in condizioni di sottomissione o subiscono violenze quotidiane, fino alla violenza più vile e più odiosa, che senza dubbio è lo stupro.
Ne Le deboli — che come si intuisce subito è un titolo usato in senso antifrastico, poiché vuol significare l’opposto di ciò che afferma — viene ribadita per l’intero racconto, attraverso la voce delle donne più anziane, quasi coréute che si esprimono in dialetto abruzzese, un’idea molto netta e probabilmente molto vera, e cioè che «sono le donne a reggere il mondo». Le deboli racconta le storie di tre generazioni di donne, dalle nonne alle nipoti, in un paesino tra le montagne abruzzesi durante gli anni Quaranta, quando alla povertà endemica si aggiunge la guerra e alla sciatteria di un mondo maschile remissivo con chi comanda e protervo con chi manda avanti la famiglia — badando ai figli, lavorando in casa e fuori — supplisce il sacrificio e la forza delle donne. Le quali hanno piena consapevolezza della loro condizione, che infatti non accettano passivamente, ma non potendo cambiare il mondo se ne fanno carico, lo «reggono», nonostante o forse grazie alla loro debolezza, che diventa la loro forza.
L’autrice è di Avezzano (L’Aquila), nella Marsica, terra di Ignazio Silone, e l’influenza del grande scrittore di Pescina in questo romanzo si sente, se non altro per la scelta di raccontare un mondo di oppressi e di «vinti», ma senza alcuna scimmiottatura né pretesa pedagogica o, peggio, senza cadere nella tentazione di applicare schemi tardofemministi a una storia che è vera storia di donne, narrata dal loro punto di vista, e sicuramente costruita anche attraverso i racconti orali ascoltati dalle donne che ottant’anni fa quella storia hanno fatto. Così può accadere che persino «l’infelicità rabbiosa» di Vincenza, costretta dal padre a sposare un uomo al quale è stata promessa, si tramuti in «felicità arresa e disperata» quando Luigi, l’uomo che ama veramente e dal quale è riamata, sposa un’altra donna del suo stesso ceto sociale. Perché quel matrimonio significherà per Vincenza poter andare a servizio in casa di Luigi, dove accadrà ciò che doveva accadere, «una unione tanto spudorata e sbagliata da essere inevitabile». Inevitabile come la figlia che metteranno al mondo. Per amore. Lo stesso amore che fa decidere ad Anna, stuprata, di infischiarsene del giudizio degli altri e di far nascere la sua bambina. Deboli?
Carlo Vulpio, Corriere della Sera, 23/8/2021


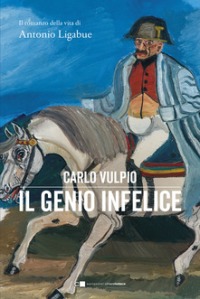



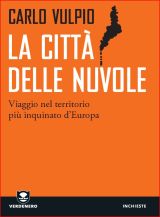


Lascia un commento