Bologna / Fu Napoleone a requisire i terreni di un ordine religioso che poi divennero fabbrica di armi e veicoli da guerra. Ora la ex Staveco aspetta una riqualificazione che secondo un gruppo di giovani professionisti deve partire dall’artigianato
Bologna
Per un latinista insigne, ma pur sempre comunista, come Ivano Dionigi, ex rettore dell’Università di Bologna, è stato più facile, o meno difficile, essere nominato presidente della Pontificia Accademia di Latinità da papa Benedetto XVI, che non riuscire, da rettore della più antica università d’Europa, nel recupero di una cittadella militare nel centro di Bologna. Dionigi voleva recuperare l’area della ex Staveco (Stabilimento veicoli da combattimento) – 9 ettari e 44 mila metri quadrati di edifici –, ma l’impegno suo e di venticinque docenti e ricercatori del suo stesso ateneo, oltre che di quattordici studi professionali bolognesi, non è bastato. Ed è stato l’ennesima dimostrazione che un apologo, per esempio quello famoso del cammello che passa per la cruna di un ago più facilmente di quanto un ricco possa entrare nel regno dei cieli (Vangelo secondo Matteo 19,24), può reggere molto di più di una «legge economica», per esempio quella famosa (e sbagliata) sulla caduta tendenziale del saggio di profitto (Karl Marx, Il Capitale).
Su viale Panzacchi, proprio ai piedi della collina del santuario di San Michele in Bosco, la facciata e il muro lungo 250 metri dell’ex Pirotecnico ed ex Staveco non lasciano minimamente immaginare «cosa c’è dietro». Quanta storia e quali storie negli edifici di questa cittadella, che è una enclave, come tutte le aree militari del resto, ma nel centro di Bologna. Vi si entra come si entrerebbe in un palazzo incustodito, da una porta d’ingresso sul viale, chiusa ma aperta, e utilizzata dai senzatetto per accedere ognuno al proprio posto-letto, fisso ma provvisorio, un giaciglio ricavato in qualche angolo di una stanza, un padiglione, una ex officina o una ex aula per lezioni di meccanica. Questa cittadella militare infatti è stata anche una delle più importanti caserme del servizio di motorizzazione dell’esercito italiano. Qui, si formavano meccanici e tecnici di prim’ordine e si progettavano, collaudavano e riparavano carri armati, blindati e altri veicoli da combattimento. Le aule erano come quelle delle università e le officine come quelle delle fabbriche, e il salto tra teoria e pratica quasi non c’era, era invece un passaggio naturale, come può esserlo un parto spontaneo.
Fu Napoleone Bonaparte, nel 1796 – erano gli anni della dominazione francese in Italia -, a segnare il destino di quest’area appartenuta ai frati Minori Osservanti fin dal XV secolo. Ne colse la «vocazione militare» per la sua posizione e la requisì. Non sbagliava, visto che in seguito, con la stessa funzione di base difensiva-offensiva, la utilizzeranno gli austriaci (dopo i moti del 1848) e i piemontesi in funzione antiaustriaca (fino al 1860), mentre l’Italia post-unitaria avrà qui uno dei suoi più forniti arsenali, oltre che fabbrica di armi, il Laboratorio pirotecnico.
Il Pirotecnico in pochi anni diventa una delle prime fabbriche di Bologna, con 330 operai nel 1886, 1.100 nel 1903 e 14 mila alla vigilia della Grande Guerra, soprattutto donne, e non solo per l’impegno degli uomini al fronte, ma perché le mani femminili erano le più adatte nella fabbricazione delle munizioni. Cosa che tuttavia non impedisce «l’incidente», un grande incendio causato dall’esplosione di 100 mila cartucce nel marzo del 1920, che venne raccontato con la consueta lezione di giornalismo da Achille Beltrame in una delle sue superbe copertine realizzate per La Domenica del Corriere, in cui l’illustrazione era «spiegata» da due righe: «Durante il panico prodotto dall’esplosione, nell’attigua caserma di artiglieria i quadrupedi abbandonavano le stalle, saltando e nitrendo, incitati dalle detonazioni», in pratica una didascalia che valeva un articolo intero.
La «vocazione militare» dell’area, naturalmente, continua a essere coltivata per tutta la seconda guerra mondiale e anche dopo, con lo stabilimento per la costruzione di veicoli da combattimento, la Staveco appunto, che è stata attiva fino al 1978. La fase finale, dopo la chiusura e prima dell’abbandono, è durata venticinque anni ed è stata scandita da altri due acronimi simili: Stavetra (Stabilimento veicoli da trasporto) fino al 1990, e Stamoto (Stabilimento materiali per la motorizzazione) fino al 2003, anno della definitiva cessazione di ogni attività.
L’idea più naturale di recupero della ex Staveco è stata sempre quella di farne un campus universitario, fin da quando, settant’anni fa, si voleva trasferire qui la facoltà di Ingegneria, la più coerente con le attività meccaniche della cittadella. E di campus si è tornato a parlare anche in anni molto recenti, quando l’ex rettore Dionigi – in base a un accordo con il Comune, che per dieci anni avrebbe agito come «soggetto trasformatore» del recupero, visto che la proprietà è del Demanio – ha messo in moto dipartimenti, docenti, ricercatori dell’Alma Mater Studiorum e professionisti di Bologna, i cui interventi e progetti sono stati raccolti in una pregevole pubblicazione, Progetto Staveco, un nuovo polo universitario tra centro storico e collina (Editrice Compositori). Tutti i lavori, al di là delle differenti soluzioni proposte e della obiezione di costituire, tutti assieme, una sorta di patchwork irrealizzabile, hanno come stella polare il concetto di «integrazione» della ex Staveco con il resto della città e con la collina di San Michele in Bosco: demolizioni parziali e nuove costruzioni con una parte dell’area da destinare a parcheggio per far «respirare» la città, strutture sportive e passeggiata verso la collina, polo per l’infanzia, mercato e spazi commerciali, un centro interreligioso, biblioteca e museo, mensa e scuola di cucina, spazi per eventi e mostre, e ovviamente residenze per gli studenti.
Troppo? Ma come, se all’estero fanno anche di più e di meglio, e in minor tempo? Certo, tra gli ostacoli va ricordato il rifiuto degli studenti di traslocare dalla sede storica di via Zamboni che, secondo loro, in questo modo sarebbe stata lasciata alle mire della speculazione immobiliare. E ne va sottolineato un altro, di natura economica, il fatto cioè che i 100 milioni di euro che si sarebbero potuti ricavare dall’alienazione della vecchia sede probabilmente non sarebbero stati sufficienti per una riqualificazione così ambiziosa della ex Staveco. Però, come scrive Cristiana Bartolomei nel lavoro citato, «in Francia un organo apposito del ministero della Difesa nell’arco di 26 anni ha realizzato un programma di riqualificazione con la cessione di 2 mila immobili», mentre i numeri della Germania sono come sempre impressionanti: dopo la caduta del Muro di Berlino, nel 1989, i tedeschi hanno chiuso 630 siti militari e hanno riconvertito 15 cittadelle militari, 7 aeroporti, 6 basi aeree, 28 caserme (pari a 2.036 ettari), 83 depositi, 49 campi missilistici e 22 centri di informazione, con quali vantaggi economici, ambientali (grazie alle necessarie bonifiche) e di carattere socioculturale è facile immaginare. Fatto sta che a Bologna, Italia, nel novembre 2016 l’Università – nuovo rettore è Francesco Ubertini – si ritrova a dover abbandonare il campo. Riconsidera l’operazione ex Staveco, la giudica una palla al piede e disdice l’accordo con il Comune. Che fare? Il Demanio fa la cosa più semplice, decide di vendere e stipula un accordo preliminare con Invimit, società di gestione del risparmio del ministero dell’Economia e Finanze, che tra i suoi compiti ha quello di valorizzare (qualunque sia il significato attribuibile a questo verbo, oggi tra i più coniugati) il patrimonio immobiliare pubblico.
Seguono mesi di sospensione nello spazio-tempo dell’incertezza e della indecisione. Fino a quando arrivano loro, un gruppo di trentenni – Sebastiano Curci, giornalista ed educatore sociale di disabili, Luca Naldi, laurea in Scienze della comunicazione e artigiano del legno, e quattro architetti, Agnese Casadio, Gianmaria Socci, Andrea Cucinotta, Francesca Ciafrè – che elaborano un progetto di recupero forse più semplice, ma non meno concreto e lo lanciano con lo stesso acronimo Staveco, che però adesso ha un nuovo significato, «Saperi Tramandati dell’Artigianato Vecchio e Contemporaneo», poiché lo scopo è quello di rivitalizzare la cittadella militare popolandola di attività artigianali sempre molto ricercate ma in via di estinzione, di botteghe e punti vendita, di laboratori e scuole tecnico-pratiche, dove l’Università mandi i suoi docenti a insegnare e le piccole aziende trovino lo spazio vitale necessario a produrre e a formare artigiani di alto livello. Nella falegnameria, l’oreficeria, la sartoria, la lavorazione dell’argilla, del ferro, del rame e del vetro, ma anche nella cosmesi, la liuteria, la produzione alimentare, fino ai laboratori di cinema, fotografia, scenografia, arti grafiche e design e, naturalmente, nuove tecnologie. La Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato, è stata la prima a crederci e a offrire il proprio sostegno al «gruppo Staveco». Poi è stata la volta di alcune piccole imprese, a cui altre si stanno aggiungendo. Ma se Comune, Università, Demanio e Invimit restano a guardare, un giocatore solo non vincerà la partita.
Carlo Vulpio, la Lettura, 11/6/2017



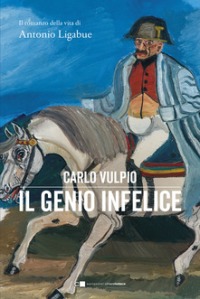



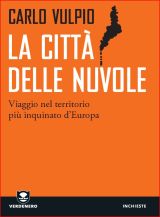


Gianfranco Fiore
Nov 21, 2017 @ 17:19:03
Ho sentito dire che dopo quest’articolo sei partito per un viaggio all’estero che dura tuttora,è vero?
Carlo Vulpio
Nov 24, 2017 @ 15:28:43
Sì, l’ho concluso due settimane fa.
Gianfranco Fiore
Nov 24, 2017 @ 19:59:27
Ah ecco perchè ora passi i commenti.Ciao e bentornato.